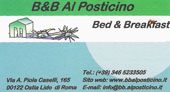“Il Cormor?” mi risponde un agricoltore di mezza età , indicando un giovane rigagnolo affondato tra due ripe erbose “è questo qui, vede?”. “E nasce laggiù, dietro la Coop, sul Monte di Buia.” Un pugno nell’occhio al povero paesaggio, la Coop, ma lasciamo perdere. “E questi gelsi?” chiedo indicando un plotone di piante mastodontiche, lavorate dal tempo e da epoche di potature. Quello che mi impressiona, oltre alle dimensioni delle piante, è che si sia salvato un filare completo. “Hanno 250 anni” mi dice “e non sa che lavoro tenerli. Ma chi ha coraggio di tagliarli?” Bravo agricoltore, penso, a te una medaglia silenziosa, oh sconosciuto benemerito.
L’erba bagnata dall’abbondante pioggia notturna mi inzuppa le scarpe mentre mi arrampico sul monte di Buia. Immergo le mani nel rigagnolo appena nato, lo fotografo, filmo l’acqua che scroscia a bassa voce. Inizia la discesa del fiume, appena con qualche incertezza laddove i cartelli che indicano l’ippovia del Cormor non sono ben posizionati. Il sentiero ondulato che ne segue il corso, a volte allontanandosene un poco, ha il fondo ghiaioso e piacevole e corre veloce sotto gli alberi che oramai stanno coprendosi di foglie. Solo una volta devo smontare perché le ruote sottili della mia tricross slittano, ma è per pochi metri. Niente salite da infarto, insomma. È un ambiente dove la natura e le buone opere dell’uomo si sono incontrate, una volta tanto. E bravo Roberto Pirzio Biroli, che ha disegnato il masterplan dell’ippovia. Mi chiedo quanto siano intervenute le sue squadre a potare, a sfoltire, a curare i boschi, perché il tutto sembra un parco all’inglese ma con un rustico accento friulano. La galleria verde, che a volte si apre in prati fioriti di tarassachi e margherite, rivela il pensiero dell’ideatore di giardini. Guardatelo con Google Earth, il capolavoro di Pirzio Biroli: è solo una striscia sottile di verde assediata da paesi e risistemazioni fondiarie, eppure l’architetto illusionista ci fa capire come sarebbe la nostra terra se fossimo stati solo un po’ più gentili con lei. Il letto del torrente è secco e i grossi ciottoli ricoperti da una cartilagine biancastra - le alghe e il fango disseccati - creano un’atmosfera da illustrazione di libro di fate. Nelle rare pozze si rispecchia un cielo che oggi è profondo, pieno di arcipelaghi di nuvole e di corvi bercianti. Ogni tanto mi fermo a fotografare e a filmare e, proprio mentre sto inquadrando un gruppo di ciclisti in arrivo - la rotta è piacevolmente frequentata da pedalatori e camminatori - resto a bocca aperta. Quello che lo zoom mi ha avvicinato sembra proprio Paolo Cosolo, ferroviere, amico d’infanzia e sparito dal mio radar da non so quanti anni. Abbasso la fotocamera, è proprio lui, partono lo stupore e gli abbracci. Non possiamo lasciarci così, senza raccontarci un po’ di cose. “E’ Emilio, un amico di Fiumicello” dice Paolo alla moglie e agli altri. Così saltano fuori coltelli, pani e salami e tante storie. Ha letto i miei libri e sa un po’ delle mie vicende sudamericane. È una mezz’ora di racconti di figli cresciuti, della passione per la bici, delle rispettive vite che ad un certo punto hanno preso direzioni diverse. Poi, una calorosa stretta di mano e il viaggio prosegue.
Il fiume, ad un tratto, è pieno d’acqua. Ancora alberi, prati, poi una casa contadina di fronte a un campo enorme dove grossi sassi spuntano dalla terra. Sto andando su e giù sulle gobbe moreniche che, sospinte dai ghiacci wurmiani, hanno trascinato a valle sassi e detriti. La terra li risputa fuori di continuo e l’arativo è cosparso di sassi. Un tabernacolo, posto al bordo del sentiero, ospita sotto vetro un Cristo e una Madonna che, da questo loro eremo silenzioso, devono aver fatto qualche miracolo minore: una chiave di casa, quella di una volkswagen e un cagnolino di plastica devono essere il ringraziamento - ipotizzo - per furto sventato, un incidente d’auto conclusosi senza vittime, e per un bambino che aveva ingoiato il Fido di polietilene rischiando di soffocare. Circa all’altezza di Pagnacco l’ippovia passa sotto gli archi di una ferrovia ormai defunta, poi appare l’autostrada, delle gru scarabocchiano il cielo ed è subito folla. Il parco del Cormor è bello ma troppo affollato per me, che vengo dal silenzio, così proseguo subito dopo aver riempito le borracce. È il momento di attaccare al manubrio l’itinerario scaricato dal sito VIVIFVG, firmato da Marco Pagavino, vademecum obbligatorio per chi voglia rifare questo bell’itinerario da Udine al mare. Passo sotto lo stadio dei Rizzi, attraverso i parcheggi deserti e dopo due chilometri imbocco via Pannilunghi. La paraciviltà del “paesaggio peristadiale” sparisce di colpo e mi trovo di fronte a un pollaio incasinato da film di Kusturica pieno di tacchini sproloquianti, vasche da bagno, secchi e una fila di gelsi che conduce a un tratturo erboso: alle mie spalle la perieria, di fronte un francobollo agrario anni sessanta. Da qui a Viale Venezia mi immergo in una Udine parallela e sommersa che non conoscevo, in bilico tra la civiltà che schiaccia e la campagna che ci finisce sotto: sottopassi, condomini, campi di calcio parrocchiali, pezzi di arativi e di città mescolati in una confusione da sogno da indigestione, quasi sempre a fianco del fiume. Scoprire che sotto casa nostra c’è un tunnel: ecco l’impressione che mi fa questo bypass alla città . Potrebbe essere la rotta che seguono i pastori per evitare questa non-Udine oltre lo specchio, dove lo specchio è rotto o sporco. Ma da un certo punto in poi è di nuovo campagna di buon carato, perché la strada bianca che inizia dopo Zugliano attraversa campi segnati da lunghe processioni di gelsi. È un Friuli ormai perso, arcaico, un resto di paesaggio da conservare e proteggere come il frammento di un affresco. Nuvole scure si avvicinano e si vedono, lontane, i sipari stracciati della pioggia che cade. Sbuco a Carpeneto, ai piedi di un monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale. Sorge sui fianchi di un modesto colle, così lontano dalle ultime tracce moreniche che non riesco a spiegarmene l’origine. Fino a Mortegliano è quasi tutta strada bianca, e ancora campi e filari di gelsi, seguendo meridiani e paralleli di una geografia che credevo scomparsa quasi del tutto. Il fiume o i canali che ne utilizzano le acque sono sempre i miei compagni di viaggio. Mentre fotografo un mulino grosse gocce di pioggia schioccano sull’asfalto, un vento freddo e repentino mi consiglia di mettermi la cerata. Per fortuna: un rovescio gelato mi avrebbe inzuppato da capo a piedi e così punto deciso verso il campanile di Mortegliano, che con la sua mole da record nazionale (”il più alto d’Italia e il quinto nel mondo” trovo sul sito del Comune) è in vista da un pezzo. Approfitto della sosta forzata per un panino in un bar, per mettermi una maglietta asciutta e per studiare un po’ la Tabacco. Quando riparto il temporale non è più sopra di me ma continua a perlustrare con la sua massa cupa e suggestiva i confini del cielo. È proprio il contrasto del viola cupo con le foglie accese e rossastre di distese di pioppi a regalarmi i momenti più belli della pedalata. La strada sterrata si dipana su uno ora sull’altro argine del fiume, che il lavoro dell’uomo ha rettificato, e l’acqua ora è calma a specchio, ora s’increspa sotto raffica. Ogni tanto delle chiuse ancora in funzione e smaltate da ruggine vecchia e piacevole giocano con la corrente creando salti, scrosci e schiume, vortici e isole galleggianti di canne tagliate. Qui si svolsero le lotte del Cormor, a cui Giuseppe Zigaina diede una mitica luce quasi notturna nei suoi quadri di operai, biciclette e badili. A parte qualche pescatore e un paio di bikers non incontro nessuno, passo sotto l’autostrada che frigge di traffico e, dopo la Triestina, una sterrata mi conduce a Carlino. Ormai quasi ci siamo. Seguo ancora l’argine su un solco battuto che adesso corre a fianco del Bosco Bando, mentre il Cormor supera gli ultimi dislivelli in sonori balzi artificiali di cemento. Adesso lo dobbiamo lasciare, il nostro fiume, e proseguire puntando sulla torre campanaria di Marano. Dopo il viale d’ingresso, a dire il vero un corteo confuso di ville e villette, il cuore del centro storico di Marano - la piazzetta con il campanile da dove scrutano, consumati e alteri, alcuni donrodrighi seicenteschi - si chiude attorno al ciclista arrivato alla meta. Per le brevi calli va un profumo di fritto che ha le stesse tinte vivaci del mio appetito. Ecco, decido adesso che la meta è una frittura mista. Adesso devo solo trovare da quale trattoria esce l’effluvio. La carta non serve più e mi affido al naso, l’ultimo strumento di questa giornata di navigazione tra terre e acqua.